da Leadership Medica n. 5 del 2007
A differenza degli altri medici il chirurgo interviene direttamente sul corpo umano con strumenti operativi cruenti, ricordandosi che nel suo agire a che fare con la vita e la morte di una persona con un nome e una storia ben precisi.
Sommario
- Introduzione
- Il rapporto medico-paziente
- I protocolli terapeutici
- Gli interventi medici
- Il problema etico centrale
- La figura del chirurgo
Introduzione
La chirurgia generale, nel corso degli ultimi anni, è stata caratterizzata da un progressivo nascere e moltiplicarsi di rami specialistici e superspecialistici che hanno permesso ai chirurghi operatori di raggiungere e superare traguardi impensabili.
Si pensi, ad esempio, alla chirurgia epatobiliopancreatica. Definita "altissima" - come tante altre chirurgie -, proprio per questo, deve essere praticata in centri definiti "di alta specializzazione".
La conseguenza immediata è che anche il paziente si rende conto di trovarsi degente in un centro di altissima qualità e il suo vissuto di malato, di degente, di operando, di operato assume una valenza peculiare. Gli interrogativi che si pone il paziente sono semplici, umani e nello stesso tempo sono, anch'essi, "altissimi": ce la farò? saprò sopportare un intervento come quello che mi hanno proposto? a chi sto affidando la mia vita in questo momento? Un'altra branca della chirurgia generale, quella trapiantologica, è particolarmente portatrice di problematiche etiche, quali il reperimento dell'organo da trapiantare, la lista di attesa, il consenso informato, tanto per citare le più importanti. Ancora, la patologia neoplastica, rispetto alle altre patologie, presenta alcune peculiarità in termini di prognosi e terapia che rendono l'alleanza tra etica e chirurgia oltremodo necessaria, non solo per il perseguimento del bene del paziente ma anche per una corretta adesione alle norme della Good Clinical Practice.
Quando si fa riferimento ai valori etici di un comportamento umano e ci si rifà alla bioetica che, in ultima istanza, definisce ciò che l'uomo "deve" fare o "non deve" fare nell'area delle scienze che riguardano la vita, non si può non presupporre l'accettazione di valori oggettivi, universali, perenni, non dipendenti, quindi, né dal soggettivismo né dal relativismo.
Ad esempio, per quanto riguarda la patologia neoplastica primitiva del fegato, va ricordata la frequente concomitanza dell'epatopatia cronica cirrogena, che condiziona una chirurgia ad elevato consumo di risorse ed ad alto rischio di morbilità-mortalità perioperatorie, mentre, d'altra parte, l'obiettivo curativo può apparire discutibile, considerata l'elevata incidenza di recidiva a breve-medio termine. Quando lo sfavorevole bilancio tra costi economici-biologici e risultati è ancora più evidente, come in alcuni casi della chirurgia oncologica dove, a fronte di elevati costi e complicanze, le percentuali di sopravvivenza a distanza risultano essere a cinque anni prossime allo zero, che fare, come decidere, con chi consultarsi? L'approccio alla chirurgia oncologica in generale non può essere esclusivamente tecnico ("si può fare!") ma deve costantemente essere bilanciato da attente considerazioni etiche ("si deve fare?"). Queste riflessioni aiutano a tener conto dei benefici previsti a fronte dei costi biologici che il malato è destinato a sopportare e delle risorse che la società deve impegnare in uno scenario che appare sempre più caratterizzato dalla necessità dell'ottimizzazione dei risultati. Non si tratta di mettere limiti alla ricerca di terapie o soluzioni sempre più efficaci, anzi! Si tratta, piuttosto, di possedere una visione d'insieme, necessariamente globale. Il medico chirurgo viene a trovarsi di fronte a molteplici scelte che i vari protocolli clinico-terapeutici gli offrono: dagli interventi chirurgici apparentemente più semplici a quelli altamente demolitivi e complessi. Problemi di natura etica emergono facilmente se si pone attenzione a questa ampia gamma di possibilità: quale la scelta "giusta"? in quale momento? per quale caso? e per "questo" paziente, di cui debbo prendermi cura, cosa devo fare?
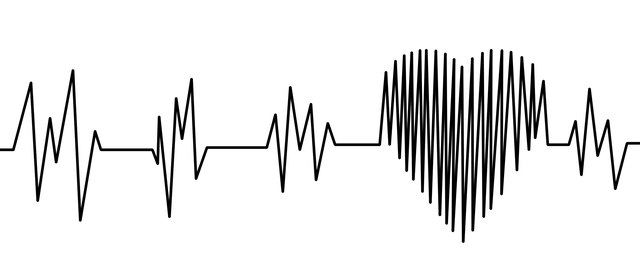
Certo, anche il rapporto medico-paziente, nel caso specifico, presenta una particolare valenza etica. Di fronte a queste problematiche il chirurgo non può non interrogarsi e porsi fino in fondo nell'atteggiamento di ricerca del significato del suo agire. Questo mio scritto desidera essere un'occasione di riflessione in questa direzione. È un problema che vorrei affrontare sotto il profilo della bioetica, ossia di quella riflessione scientifica e sapienziale che considera le più diverse questioni della vita (bios) in riferimento ai valori e alle esigenze più radicali dell'uomo nella sua specifica dignità di persona (ethos). La mia vuole essere una riflessione razionale, che ha nell'intelligenza e nella ragione umana il suo criterio di lettura e di discernimento: è, dunque, una riflessione per sua natura aperta a tutti e da tutti, almeno in qualche modo, condivisibile. Quando si fa riferimento ai valori etici di un comportamento umano e ci si rifà alla bioetica che, in ultima istanza, definisce ciò che l'uomo "deve" fare o "non deve" fare nell'area delle scienze che riguardano la vita, non si può non presupporre l'accettazione di valori oggettivi, universali, perenni, non dipendenti, quindi, né dal soggettivismo né dal relativismo.
Nuove domande etiche scaturiscono dall'applicazione
dei progressi terapeutici e degli interventi medici.
Nella esposizione che segue, farò riferimento alla concezione dell'uomo inteso come "persona", assumendola come parametro di valore, di misura e di giudizio. L'uomo come persona è il criterio fondamentale di eticità. Persona è l'essere umano nella sua totalità unificata, cioè in tutte le sue componenti e dimensioni, integrate ed unificate indivisibilmente nell'"io" personale. Nella dignità dell'uomo inteso come "persona" sta il fondamentale criterio morale oggettivo, universale e perenne. Quando il medico si rivolge al malato e ne ha cura, che cosa cura? Egli è chiamato a pensare a un tutto, superiore alla parte malata e all'insieme delle parti, ricorda il filosofo Massimo Cacciari. Infatti, è possibile curare senza pensare alla dimensione invisibile che supera la parte, l'insieme delle parti? L'insieme delle parti è qualcosa che le uniforma tutte. Che cos'è? E' soffio, vento, anima, psiche, respiro non riducibile alla parte né alla somma delle parti. E', dunque, possibile curare senza riferirsi a tale sovrasensibile? Non si dà cura se non si fa riferimento all'anima: c'è un tutto superiore alle parti. Ci si imbatte in qualcosa di indefinibile e dobbiamo averne cura. Aver cura significa, allora, avere misericordia e cioè essere capaci di "scardinarsi", di scardinare il proprio cuore di fronte al malato: fare fatica, avere angustia, angoscia nei confronti del malato che diventa prossimo. Dal recupero della salute si giunge alla scoperta della bellezza: il bello diventa sentire uno spasmo al cuore per il sovrasensibile. Bello è avere cura dell'anima curando il corpo: la cosa più difficile.
Occorre dialogare col paziente da paziente: insieme cercare la "firmitas" che ci manca. Per questo, di fronte a quello che occorre fare, è necessario innanzitutto "cogitare" che significa "agitarsi", altrimenti - sottolinea Cacciari - il medico è solo un meccanico. Ne consegue l'ineluttabilità di "ascoltare". La tecnica medica si accompagna all'ascolto, alla riflessione. Etica e chirurgia sono chiamate, naturalmente, ad allearsi. La riflessione bioetica, in tema di malattia, permette di cogliere alcuni importanti aspetti che, secondo Dionigi Tettamanzi, riguardano innanzitutto il malato stesso e il suo comportamento morale di fronte alla malattia che lo provoca. Il malato è chiamato ad affrontare la sua malattia da essere morale; è invitato, cioè, a raggiungere liberamente il fine della sua piena realizzazione. La moralità è propria e specifica dell'uomo in quanto tale perché egli osserva di essere "ordinato" a dei valori, primo fra tutti il bene, la perfezione, la realizzazione piena di se stesso, e quindi il raggiungimento della felicità. Inoltre, l'uomo sa di essere cosciente e libero, responsabile di autoordinarsi liberamente al fine, anche se la sua consapevolezza in realtà viene ad essere ferita dallo stato di malattia. Infatti, come l'esperienza insegna, l'umanità del malato viene messa a prova proprio dalla malattia stessa nei suoi molteplici aspetti. Il malato, infatti, viene intaccato nella sua umanità e nella sua unità psicofisica, segnata da tensioni o addirittura da lacerazioni (il corpo non ubbidisce facilmente allo spirito; altre volte lo spirito fatica ad esprimersi); nella sua relazionalità, resa difficoltosa nel rapporto con gli altri e comunque costretta a forme di separazione e di solitudine; nella sua religiosità e fede, sfidate dalla nuova situazione e chiamate a dare risposta al "perché" del male di fronte alla bontà di Dio. Di fronte alla malattia, ad ogni malattia, quella oncologica compresa, l'uomo intelligente e libero si pone un inquietante interrogativo: come posso, in questa situazione di malattia, vivere da uomo? Vivere in coerenza con la moralità che mi segna profondamente? Come posso esplicitare la mia libertà responsabile? E la bioetica, di fronte alle domande che sorgono dal campo così ampio e in continua evoluzione della oncologia, quali risposte offre? Difficile trovarle scritte nei libri o nei trattati. Eppure è necessario cercare e ricercare "la" risposta.
2. Il rapporto medico-paziente
Il rapporto medico-paziente che si instaura quando occorre mettere in atto una terapia antitumorale, che prevede nella maggior parte dei casi un approccio multidisciplinare (chirurgico, chemioterapico, radioterapico), è del tutto peculiare. Il medico, infatti, sa che non può mentire, anche se a volte è restio a comunicare la verità, particolarmente quando il rapporto medico-paziente, che avviene fra un paziente e molti medici che lavorano in équipe, può comportare una sorta di deresponsabilizzazione: quale dei medici dell'équipe deve dire la verità al malato? Il medico non dovrebbe mai mentire, specie in questo tipo di rapporto ove l'atto terapeutico proposto, nella grande maggioranza dei casi consisterà, ad esempio, in un atto chirurgico il cui risultato finale non potrà non compromettere l'integrità anatomica dell'organo interessato dalla patologia; e di ciò il paziente non potrà non rendersi conto. In realtà oggi, di fronte ad interventi chirurgici, semplici o complessi che siano, i pazienti sono portati a credere di non essere affetti da una neoplasia e, a volte, il medico glielo lascia credere. Si pone, allora, il problema della "verità al malato"; dire o tacere? Certamente questo problema tocca l'ambito dell'etica del medico in generale ogni volta in cui egli intesse un rapporto col paziente, ma nel nostro specifico caso ne costituisce un momento cruciale. Se si afferma che il malato ha diritto di sapere la verità, questa dev'essere detta in un contesto di dialogo fiducioso. Non ci si può limitare a fornire dati ed elementi di diagnosi, terapia e prognosi, fuori dall'ambito di una cordialità di rapporti. Il medico è invitato a coniugare il suo sapere scientifico con gli elementi di una nuova antropologia, quella che Jean Francois Malherbe, filosofo della medicina, vuole "basata sul personalismo e che abbia come asse portante la concezione dell'uomo come essere di parola e di comunicazione". La parola si concretizza nel dialogo e il buon andamento dell'atto terapeutico dipende essenzialmente dal rapporto di fiducia che si instaura fra medico e paziente. La domanda che il paziente rivolge al medico è che gli venga restituita la salute o, nei casi estremi, la speranza.
Questa non può essere comunicata da un anonimo nozionismo, né tantomeno da uno strumento tecnologico ancorché raffinatissimo, bensì da un persona vivente e pensante. E quando il dialogo ha per tema la malattia oncologica, il medico si vede coinvolto, nell'affrontare questi problemi in un modo particolare. In realtà il medico sa che la malattia tumorale non deve essere demonizzata; essa è una malattia come le altre, ma le implicazioni socio-culturali e gli specifici vissuti di ciascuno danno, di fatto, a questa malattia una valenza particolare. Qualcuno dice che il medico deve munirsi di un certo grado di "anaffettività" per poter essere obiettivo nei giudizi. In realtà vi è un aspetto di distacco critico ed emozionale che partecipa di uno sforzo di necessaria saggezza, consapevole della grandezza insita negli eventi decisivi di ogni storia umana. Ma questo non toglie che il medico, che è uomo come è uomo il malato, con la sua sensibilità divenga necessariamente partecipe dei sentimenti e delle sofferenze del paziente, senza lasciarsi sopraffare da essi. E il malato, quand'anche non capisca nulla dell'agire medico in senso stretto, avvertirà invece in pieno la partecipazione umana con cui viene seguita la sua vicenda. E' soprattutto così che il medico conquista la stima e la fiducia del suo paziente. Solo allora sarà possibile attuare una comunicazione della verità con modalità progressiva e criteri pedagogici e si renderà il malato capace di conoscere, giorno dopo giorno, un po' più di verità. Il medico gliela potrà rivelare completamente quando il paziente sarà in grado di accettarla in modo positivo. Nel delicato compito di "dosaggio" della verità, il medico mette alla prova tutta la sua preparazione psicologica, la sua sensibilità, la sua "arte", anche se difficilmente potrà dire di avere trovato, nella sua carriera universitaria, dei maestri in questi specifici campi. Non si tratta tanto di sapere quello che si deve dire. Ciò che conta è il "come" si dice e si comunica. La comprensione umana, basata sulla prudente gradualità, non potrà mai confondersi, però, con la falsificazione dei dati oggettivi riguardanti una proposta di trattamento o la natura della malattia. Per questo motivo è richiesto al medico di avere nozioni di psicologia. Sarebbe troppo facile fare ricorso allo specialista in materia, ma così operando si frammenterebbe sempre di più il rapporto medico-paziente che deve rimanere, per quanto possibile, unico e insostituibile. In un'epoca di superspecializzazioni, quale la nostra, è necessario ricondurre ad unità le prestazioni terapeutiche se si vuole mantenere "umano" il rapporto fra il medico e il paziente. Questo rapporto, come ho avuto modo di rimarcare, è di fondamentale importanza nell'impostazione clinica e terapeutica e ha dei risvolti etici precisi, nel senso che è necessario che avvenga in un determinato modo e non in un altro.
I vari protocolli terapeutici adottati hanno implicazioni di natura etica per il medico che, consapevole della continua evoluzione delle terapie, deve saper proporre ciò che ritiene ordinario e proporzionato per il paziente. Il paziente, poi, correttamente informato sulle varie possibilità esistenti decide liberamente l'accettazione o meno della terapia. Quello che viene proposto al paziente rientra nel rapporto fiduciario che si è realizzato con il medico curante, quando la cura indicata riguarda un preciso stadio della malattia che prevede un trattamento standardizzato e consueto. Maggiori rilievi di natura etica si evidenziano quando "si inseriscono" i pazienti in protocolli sperimentali. Dal punto di vista etico occorre che siano rispettate le raccomandazioni in materia, formulate da organismi nazionali ed internazionali.
Ricordo le "Raccomandazioni a guida dei medici nelle ricerche biomediche" promulgate dall'Associazione Medica Mondiale (Helsinki 1964; riviste negli anni successivi, l'ultima nel 2000), la Good Clinical Practice for Trials on Medicinal Products in the European Community, i decreti ministeriali italiani del 1997, 1998, 2006, specie quelli riguardanti la costituzione e il funzionamento dei comitati di etica ospedalieri.
Il comportamento etico corretto è quello che più di altri riesce a salvaguardare tutte queste esigenze, rispettando alcune norme precise:
- quella relativa al controllo scientifico (è necessario fare riferimento a rigorosi principi scientifici generalmente riconosciuti);
- quella relativa al rapporto rischi-benefici (i benefici di una ricerca sull'uomo devono essere proporzionati al rischio del danno che può essere inflitto);
- quella relativa al consenso informato (è la norma più rilevante dal punto di vista etico di tutta la sperimentazione). A volte, specie quando i pazienti si presentano tardivamente all'osservazione medica con un quadro clinico di particolare gravità (la malattia viene ormai definita inguaribile), al medico si pone il dubbio se sia etico sottoporre ugualmente il malato a terapie aggiuntive. Il non far nulla potrebbe apparire una resa incondizionata di fronte al cancro che ha ormai compiuto la sua opera devastatrice; il fare "di più" potrebbe giudicarsi accanimento terapeutico. La risposta va ricercata all'interno della "gestione" dei casi singoli e concreti che mai potranno diventare termine di paragone per altri casi: il saper in partenza che non sarà possibile realizzare tutto ciò che occorre per ottenere il bene totale del malato non significa che è proibito mettere in atto quei minimi accorgimenti che consentano al paziente di vivere almeno con dignità gli ultimi suoi momenti. Le cure palliative rendono più sopportabile, in tutti i sensi, la propria malattia. Si tratta di compiere quello che il mio maestro nell'arte chirurgica, prof. Amleto Bissi, soleva definire "intervento chirurgico samaritano". Un'attenta valutazione etica va posta anche quando ci si trova di fronte a ricadute della malattia nonostante gli atti terapeutici messi in atto. Se all'inizio della malattia l'obiettivo primario per il medico era il ripristino della salute con la guarigione del paziente, ora l'obiettivo secondario è lo "stabilire" i mesi di sopravvivenza e la qualità di vita del paziente. In questo delicatissimo lavoro di equilibrio fra il decidere se ricorrere a mezzi proporzionati o sproporzionati di terapia, fra la lotta ad oltranza contro la malattia o la resa di fronte alla realtà delle cose, sta la capacità del medico di intessere un dialogo con il paziente e i suoi familiari nel rispetto assoluto della scelta che solamente il paziente dovrà compiere. Tale scelta, pur sofferta, troverà sollievo dal conforto che i familiari e il medico saranno capaci di offrire con dignità ed umanità. Queste affermazioni richiedono chiare risposte ai seguenti interrogativi: chi stabilisce se un atto medico è proporzionato o meno al caso concreto? Ciò che è accanimento per uno è o deve essere ritenuto tale anche da altri? E' il paziente o il medico che definisce ciò che è "accanimento terapeutico"? E' la comunità scientifica che deve intervenire a dirimere il dubbio con linee guida? Come coinvolgere i parenti senza venir meno a quanto stabilisce la legge sulla privacy? Ritengo che una attenta e precisa responsabilità etica e professionale possa aiutare il medico a trovare le risposte a questi interrogativi, mai dimentico che può sempre incorrere in errori di valutazione sia in senso prognostico che diagnostico. E' quel "quid" di saggezza in più, che ogni medico deve sapere di avere dentro di sé, che permette di trovare, come una bussola che sa evitare gli scogli per prendere il largo, "la" soluzione in piena sintonia con il paziente e con il parente. Un aiuto concreto al medico può venire anche e soprattutto dal dialogo con altri colleghi all'interno di un organismo, quale ad esempio il comitato di etica ospedaliera, che può offrire un momento di riflessione pluridisciplinare ed un parere sulla linea da percorrere.
Nuove domande etiche scaturiscono dall'applicazione dei progressi terapeutici e degli interventi medici. L'utilizzo scientifico e terapeutico delle cellule staminali fa emergere un interrogativo etico, quello che riguarda la fonte del prelievo delle cellule staminali. La fonte può essere l'adulto, il cordone ombelicale, l'embrione. L'ultima scoperta, in ordine di tempo, il liquido amniotico. Nel caso dell'utilizzo dell'embrione sorgono seri problemi etici, quando l'intervento comporta la morte dell'embrione stesso. Anche la proposta di nuove terapie in campo oncologico crea un'aspettativa ansiosa se non spasmodica verso i risultati della ricerca, al punto che con facilità si finisce per accogliere ogni possibile proposta. In realtà, vale la pena di ricordare come la deontologia e l'etica esigano che ogni trattamento proposto sia sottoposto a verifica. La sperimentazione, prima dell'impiego su pazienti, è di fondamentale importanza, perché si devono conoscere non solo i risultati a breve termine (un eventuale miglioramento), ma anche quelli a lungo termine (un improvviso peggioramento). In questa prospettiva andrebbero considerati tutti gli interventi - di provata efficacia - abitualmente messi in atto per sconfiggere la malattia e comunque per migliorare la salute del paziente. Da un punto di vista etico occorre verificare che gli interventi medici non risultino, in qualche caso, inadeguati o addirittura si configurino come accanimento terapeutico. I francesi utilizzano il termine acharnement thérapeutique, mentre gli inglesi usano overtreatment. Queste parole stanno ad indicare, più che un preciso e conosciuto comportamento, un'ostinazione nel perpetuare un'azione che nel giudizio comune è considerata deplorevole. Nel termine "accanimento" sono insiti due significati, evidenziati dalla terminologia anglosassone: l'eccesso e l'irrazionalità. Overtreatment sottolinea lo spreco, tace sul rischio, non esplicita le alternative e il peggioramento della qualità di vita. Il termine francese acharnement indica sia la rabbia e la cecità delle prospettive, sia la perdita del senso di responsabilità personale e "l'agire in conformità col comportamento del gruppo, assimilato ad una muta di cani intenti a sbranare la preda". (C. Besana).
Per P. Cattorini e M. Reichlin la caratteristica essenziale che contraddistingue l'accanimento terapeutico sta nella "tendenza a dare esclusiva pertinenza all'aspetto biomedico nella determinazione del bene del paziente nella fasi terminali della malattia: si tratta dunque di un atteggiamento che conduce a privilegiare il ripristino della funzionalità di una parte rispetto al benessere del tutto, ad inseguire -il più delle volte inutilmente- la salute dell'organo dimenticando quella della persona". C. Casalone definisce l'accanimento terapeutico il 0"prolungamento della vita fisica non rispettoso della dignità della persona". La proporzionalità delle cure deve essere valutata tramite una comparazione: da una parte alcune caratteristiche che attengono ai mezzi terapeutici in se stessi, come la reperibilità, i costi, gli oneri psico-fisici e i rischi della loro applicazione; dall'altra i benefici attesi e la loro corrispondenza con il mondo di valori e la visione di vita buona che è propria del paziente. Il Comitato Nazionale per la Bioetica (14 luglio 1995) lo definisce come un "trattamento di documentata inefficacia in relazione all'obiettivo, a cui si aggiunga la presenza di un rischio elevato e/o una particolare gravosità per il paziente con un'ulteriore sofferenza, in cui l'eccezionalità dei mezzi adoperati risulta chiaramente sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica".

Questi criteri vengono ripresi da D. Tettamanzi che così li elenca:
- L'inutilità o inefficacia sotto il profilo della terapia (a tale criterio si riconnette, contenutisticamente, quello dell'irreversibilità o della morte cerebrale). Già alla luce di questo primo criterio risulta contraddittoria la stessa espressione di 'accanimento terapeutico', precisamente perché non conduce alla terapia.
- La penosità o gravosità sotto il profilo del malato, che rischia d'essere posto in condizioni di ulteriori sofferenze o anche di umiliazione profonda. Alla luce di questo criterio il termine 'accanimento terapeutico' svela la triste realtà d'essere un accanimento non sulla malattia, bensì sul malato. In questo senso, alcuni parlano di 'violenza' terapeutica.
- L'eccezionalità degli interventi e/o dei mezzi terapeutici: sono quei mezzi che i moralisti del passato qualificavano come 'straordinari' e che oggi si preferisce definire 'sproporzionati'.
E' evidente che questo terzo criterio è soggetto di fatto all'evoluzione in rapporto al tempo e allo spazio: mezzi un tempo e in certi paesi 'sproporzionati', oggi e da noi (paesi sviluppati) sono da definirsi mezzi 'proporzionati'. Comunque questo terzo criterio precisa meglio quello dell'inutilità: il trattamento risulta inutile nonostante la sua eccezionalità. Da queste molteplici definizioni, si può ricavare - in termini generali - con chiarezza che l'accanimento terapeutico non può essere né accolto, né giustificato in alcun modo.
Perché si arriva all'accanimento terapeutico? Un ruolo importante è esercitato dal medico quando, consciamente o meno, si rifà ad una impostazione filosofica che va sotto il nome di vitalismo. La vita viene considerata unicamente dal punto di vista biologico senza alcuna attenzione agli aspetti psico-spirituali ed etici del paziente. Secondo questa filosofia, per il medico il "bene" dell'uomo che sta curando è la sola e semplice conservazione della vita in quanto tale. In realtà, il medico dovrebbe comprendere che "bene" in senso proprio, in senso di un imperativo morale, è ciò che contribuisce alla pienezza dell'umanità, al maggior dispiegamento delle potenzialità umane; bene in senso assoluto è quello della "buona causa" per la quale si può decidere di impegnare la propria vita sino a perderla. Ne consegue che la cosiddetta vita fisica non può in nessun caso essere considerata un valore assoluto anche se questa affermazione non significa che la vita sia alcunché di estraneo al valore morale: la vita è piuttosto un valore fondamentale nel preciso senso per cui esso è condizione di possibilità di ogni altro valore. Altre volte il medico è spinto ad accanirsi nella ricerca di una terapia per una forma di paternalismo esagerato. E' lui che decide ciò che si deve fare per il bene del malato perché lui sa in che cosa consista questo bene. Ormai questa forma di esercizio della medicina va considerata superata perché il principio di autonomia del paziente, che garantisce l'esercizio della libertà, è ormai del tutto accettato e riconosciuto. Ancora è la fiducia incrollabile nella "macchina", intesa quale strumento di supporto delle funzioni vitali, a caratterizzare taluni comportamenti sanitari. Così operando si procrastina sempre di più il momento della morte a scapito della dignità del morente, dignità che mai può venire meno, in nessuna circostanza. L'avvento dello sviluppo tecnologico ha permesso di debellare molte malattie. Il progresso ha avuto anche, però, conseguenze negative: il miglioramento e la razionalizzazione dell'assistenza al malato ha spesso comportato anche un spersonalizzazione del rapporto medico-paziente. Descrive molto bene questo fenomeno il documento, prima citato, del Comitato Nazionale per la Bioetica : "…l'arricchimento del sapere scientifico si è accompagnato ad un diffuso impoverimento della componente 'umanistica' della medicina, il cui oggetto era quello di lenire anche le sofferenze psicologiche e spirituali che alla malattia si accompagnano. La disponibilità di strumenti diagnostici e terapeutici sempre più efficienti, sicuri, maneggevoli comporta il rischio di un abuso consistente nel rivolgere eccessiva ed esclusiva attenzione alla valutazione degli effetti della tecnica adottata, compromettendo il delicato rapporto umano con il paziente. Questo abuso viene denominato 'tecnicismo'. E' bene ricordare, dunque, che la tecnologia assume valore finché rimane al servizio del paziente; ma quando si limita a servire la scienza, finisce per favorire la 'disumanizzazione della medicina', con grave danno sia per il paziente che per il curante". Il contesto complessivo del sistema delle cure altamente specializzato e in costante sviluppo conoscitivo impedisce al medico di dare spazio, correttamente ed opportunamente, alla medicina palliativa competente e umanizzante. Un problema oggettivo e reale per il medico è stabilire la proporzionalità delle cure. Quali i criteri su cui basare la scelta? Quale regola seguire? Una attenta riflessione su queste problematiche fa comprendere come non possa esistere "una" regola, "una" scelta, "una" decisione. Un trattamento che può essere definito giustamente sproporzionato in un caso, può essere invece del tutto proporzionato in un altro. Questo perché il concetto di proporzionato e sproporzionato non riguarda soltanto la tecnica, ma anche e primariamente le condizioni soggettive dell'infermo. Un trattamento può essere inaccettabile per uno ed accettabilissimo per un altro: si pensi a trattamenti ad alto rischio, ad amputazioni degradanti gravemente la qualità della vita. Se il dibattito rimane aperto e problematico, sta alla coscienza dei vari interlocutori di poter trovare le singole vie di uscita. Si giunge così al cuore del problema: quale coscienza? Fondata su che cosa? A quale scuola di medicina e scienze umane si indirizza, oggi, il medico? E' abituato a riflettere, a pensare, a motivare le scelte terapeutiche? Oppure si lascia guidare unicamente dall'onnipotenza di un sapere tecnico-scientifico, completamente dimentico del senso umano del suo procedere? Scienza e umanesimo devono confrontarsi, devono unirsi, devono aggregarsi all'unisono. Nell'epoca storica attuale la medicina tecnologica non può non allearsi alla medicina filosofica: nullus medicus nisi philosophus recita un antico aforisma.
Da Ippocrate in poi la medicina si esercita fra téchne e valori umani. Allora, tecnologia e antropologia coincidono: il medico ippocratico è l'archetipo del medico impegnato tecnicamente e coinvolto umanamente. Nel Medioevo e nel Rinascimento la relazione fra medicina e filosofia è ancora molto stretta: la salus è interpretata come salvezza dell'anima e salute del corpo. Cartesio pone le premesse dell'homme machine: organismo da misurare e riparare. Il medico diventa uno "iatromeccanico". Il dualismo cartesiano tra corpo e mente, tra soma e psiche, fa del medico uno specialista del corpo-diviso e pone le basi della manipolazione totale del corpo. Da Cartesio in poi il divario si approfondisce sempre di più e oggi, accanto ad una necessaria specializzazione ed avanzata tecnologia,viene denunciata da più parti la perdita della nozione filosofica della visione unitotale dell'uomo. Occorre recuperare questa visione olistica: la vita dell'uomo è l'uomo stesso nella sua completezza ed integrità di un tutt'uno soma-spirito, senso-conoscenza, intelligenza e saggezza, corporeità e trascendenza. La Scuola di Medicina deve farsi garante della formazione globale e permanente dei medici, favorendo l'integrazione del sapere tecnico-scientifico con quello filosofico-umanistico. Se questo connubio non dovesse realizzarsi, il medico sarebbe un medico monco, un tecnico del corpo in grado, nei migliore dei casi, di curare un organo malato, mai di prendersi cura della persona malata. Questa coscienza unitaria che sa coniugare costantemente tecnica e umanesimo, deve permeare la coscienza di ogni medico. Non può essere ritenuta una semplice opportunità o, peggio, una perdita di tempo. Dalla visione olistica derivano importanti e straordinarie conseguenze:
a) il malato si sente accolto e rispettato nella sua dignità e libertà personali;
b) viene messo nella condizione di partecipare col medico al piano di cura predisposto per la soluzione terapeutica della sua malattia;
c) sa cogliere, nella sua essenza, il valore umano della partecipazione del medico che lo accompagna nel momento della malattia lungo tutto il suo naturale decorso. Il medico trova, da questa concezione, un'altrettanta straordinaria motivazione per il suo operare. Ritornando al problema dell'accanimento terapeutico, un medico siffatto è in grado di appellarsi alla sua coscienza retta, illuminata, giusta. Rimane aperto, poi, il problema di chi decide sull'utilità o meno di un trattamento medico. Si tratta di un argomento non indifferente: infatti, in un sistema sanitario dotato di risorse limitate come non osservare l'importanza di separare i trattamenti medici utili da quelli inutili o futili? Scaturisce l'esigenza di elencare i bisogni reali che necessitano una adeguata e giusta riposta da parte del servizio sanitario per una allocazione altrettanto giusta ed adeguata delle risorse. Se, sotto il profilo etico, viene escluso l'accanimento terapeutico che si configura realmente come tale, è da escludere anche quello che si suole chiamare "abbandono terapeutico". In tal senso occorre impegnarsi nell'uso proporzionato dei mezzi terapeutici, cioè di quei rimedi che si ritengono ancora utili e necessari e la cui sospensione risulterebbe inaccettabile omissione.
E' la formazione etica del medico-chirurgo. Come favorirla? Il 7 settembre 1991 il Comitato Nazionale per la Bioetica ha prodotto un documento su "Bioetica e formazione nel sistema sanitario". Nel documento vengono sottolineati importanti aspetti, alcuni dei quali vengono qui di seguito riportati. La formazione etica è necessaria è necessaria in quanto:
1. il contesto culturale odierno, entro il quale si trova ad operare il medico, preferisce privilegiare la super tecnologia plurispecialistica a discapito del rapporto umano irrimediabilmente alla ricerca di un perché della sofferenza, della malattia, della morte. Oggi, ricorda Hans Jonas, "tremiamo nella nudità di un nichilismo che unisce il massimo di potere intorno ai mezzi con il minimo di sapere intorno agli scopi" ;
2. la frammentazione e la disseminazione del sapere scientifico sfida il potere sintetico della ragione ritenuta inidonea a cogliere la visione dell'insieme, aprendo spazi sempre più grandi a semplificazioni ed irrigidimenti ideologici;
3. la profonda crisi che ha colpito l'esercizio della medicina (è arte? è tecnica? è scienza?) sembra non trovare vie d'uscita. Il passaggio culturale da una medicina della malattia ad una medicina per la salute, ha modificato fortemente il contesto sociale e sanitario nel quale si svolge la professione del medico, e notevolmente aumentato il numero dei professionisti, laureati o diplomati, abilitati a svolgere mansioni e interventi rivolti alla popolazione, anche per "l'importazione" di figure professionali, prima inesistenti nel nostro Paese, proposte e recepite dalla nostra legislazione in base alle Direttive europee. Stiamo assistendo ad una divaricazione tra medicina e sanità. La divaricazione più preoccupante è tra i "fini" del sistema sanitario e i "fini" della medicina.
Nel primo caso prevale l'intento economicistico, nel secondo caso si assiste ad un crescente controllo dei comportamenti professionali e attraverso ciò ad una subordinazione dei fini in quanto tali. Da questo divario di "qualità" tra medicina/sanità nasce anche il problema della delegittimazione sociale della medicina e, di conseguenza, della perdita di credibilità del medico. A fronte di una crisi paradigmatica della medicina si risponde con una sanità dominata da una logica economicistica, nella quale si consuma un processo crescente di delegittimazione sociale che prima di tutto riguarda il medico.
Oggi la medicina si trova tra la spada e il muro.
Da una parte "l'esigente", dall'altra "i conti dello Stato". L'educazione etica deve rappresentare un processo attraverso il quale le norme e le regole, tipiche della professione esercitata, illustrate e fatte conoscere dai docenti agli allievi, vengono fatte proprie (nel senso di una loro interiorizzazione) dai soggetti interessati Ma, in definitiva, che cos'è l'etica? Risponde Dionigi Tettamanzi: "L'etica non è qualcosa di frenante, bensì qualcosa di liberante. […] L'etica non è qualcosa di estrinseco o di sovrapposto, bensì qualcosa di intrinseco alla persona; non è imposta dall'esterno, ma è stampata dentro la persona stessa.
In realtà, non sono gli altri ad imporre a noi le esigenze etiche, ma è da noi stessi che provengono queste istanze: da noi stessi, ossia dal nostro stesso essere di persona, considerato nella sua struttura, nei suoi dinamismi e nelle sue finalità".
Del tutto peculiare è il rapporto che lega il chirurgo al corpo umano. A differenza degli altri medici, il chirurgo è chiamato dalla sua professione ad intervenire direttamente sul corpo mediante strumenti operativi cruenti. Per questo motivo, di fatto, il corpo si presenta al chirurgo nella sua veste materiale, staccato dalle altre dimensioni, quella intellettuale e psichica, che - viste nella loro unità con la dimensione materiale - costituiscono l'individuo, la persona umana. Questo distacco non impedisce al chirurgo di ricordarsi che nel suo agire ha a che fare con l'uomo, ma nel momento dell'intervento il rapporto diretto che si va instaurando è fra chirurgo e corpo.
Sotto la luce forte e chiara della lampada della sala operatoria, con il campo ben illuminato, il chirurgo diventa un tutt'uno con il corpo che, inerme per l'effetto degli anestetici, giace sul lettino operatorio. E' sempre una battaglia, una lotta per estirpare il male che, spesso, nelle forme più gravi ed avanzate di cancro, presenta tutta la sua nefasta potenza aggressiva.
E il chirurgo impegna in questa lotta tutto se stesso: non sono soltanto le mani, sotto la guida della mente, a compiere il gesto, ma tutta la sua persona partecipa, in uno stato di tensione e di stress che, pur controllato col passar del tempo dalla maturità e dall'esperienza, spesso esplode in momento di rabbia, di angoscia, di dolore quando l'imponderabile sopraggiunge. A volte, come padrone assoluto di quel corpo entro i cui visceri le sue mani, o i nuovi strumenti tecnologici dalle mani guidate, incessantemente si muovono, il chirurgo non vuole ammettere di trovarsi di fronte a limiti invalicabili.
E così il bisturi continua ad incidere, a tagliare, a togliere. Oppure il corpo offre il "caso", quello per cui vale la pena di fare una comunicazione o una pubblicazione scientifica. E allora esso non ha più età né sesso, né condizione sociale. Ciò che conta sembra essere soltanto che quell'atto chirurgico entrerà nella casistica. Ma nella maggioranza dei casi, nella trovata identità fra corpo e chirurgo, quest'ultimo sa che ogni corpo ha un nome, un sesso, una condizione sociale precisa.
La compassione, come "patire con" quel corpo, che non è più anonimo ma è persona, è un sentimento che il chirurgo, più di altri, può provare in modo singolarmente profondo e costituisce la sua dimensione veramente umana che lo fa solidale con il paziente. Non si può ignorare, ad esempio, che si sta cercando di salvare la vita ad un traumatizzato della strada o che l'intervento di exeresi di una neoplasia che ha colpito una giovane esistenza, la restituirà alla vita. Non esiste la figura del chirurgo privo di sentimenti.
Non sarebbe medico. E proprio per il tipo di lavoro che svolge, il chirurgo - col passare degli anni - acquisisce un marchio indelebile di umanità autentica che cambia, completa, caratterizza la sua personalità. Indicativa del peculiare rapporto umano fra chirurgo e paziente è la fiducia che da questi è concessa al medico che "metterà mano" a togliere il male: "Dottore mi opererà lei, vero?" Oggi ogni intervento, si può dire nella stragrande maggioranza dei casi, risulta essere, al suo termine, perfettamente riuscito. Nei casi più complicati il decorso post operatorio viene seguito nelle sale di terapia intensiva.
Nessun problema quindi per il chirurgo? La risposta è chiara: i problemi esistono perché il chirurgo non può dimenticarsi che il corpo è solo una dimensione dell'uomo che va considerato un tutto unico. Infatti il corpo umano non è riducibile ad un fenomeno bio-fisiologico tutto e solo identico al corpo non umano: esso è profondamente segnato dall'affettività e dalla spiritualità della persona. Il chirurgo nel suo operare deve saper cogliere il limite del suo agire. Esso è dato dal riconoscere attraverso il corpo, un uomo, una persona, un suo simile. Salvare il corpo o salvare l'uomo? Non è solo un interrogativo retorico. E' chiaro che occorre salvare l'uomo che è anche corpo, ma quando l'intervento chirurgico, per l'esperienza acquisita, presenta gravi rischi per la continuità di una vita che sia veramente tale, occorre riflettere sulla sua eticità. Mi piace pensare, in definitiva, che l'intervento del chirurgo sul corpo umano malato appartenga in qualche modo all'atto originario della creazione, pur se, nella sua metodica fondamentale, toglie e demolisce. Ma ridona la vita e questo attraverso un suo gesto proprio, diretto, diverso da qualsiasi altro atto medico. Di fronte al malato il medico deve saper cogliere in se stesso tutte le componenti umane del suo essere: scienza, coscienza, umanità si devono intrecciare in una sensibilità e in una delicatezza ineffabili. Routine, superficialità, faciloneria, grossolanità, presunzione non possono e non devono trovare spazio nelle corsie dell'ospedale. Da ultimo, il medico non dimentichi mai di dialogare, di sostenere, di confortare "anche" il parente o l'amico del malato. Oggi è diventato imperativo riandare alle fonti del proprio sapere medico e riscoprirne il carattere più autentico e radicale: essere "custodi e servi" della vita umana. Questa è l'alleanza che coniuga l'etica e l'agire medico.
Alfredo Anzani
Docente di Etica Clinica, Scuole di specializzazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Vita Salute San Raffaele, Milano




